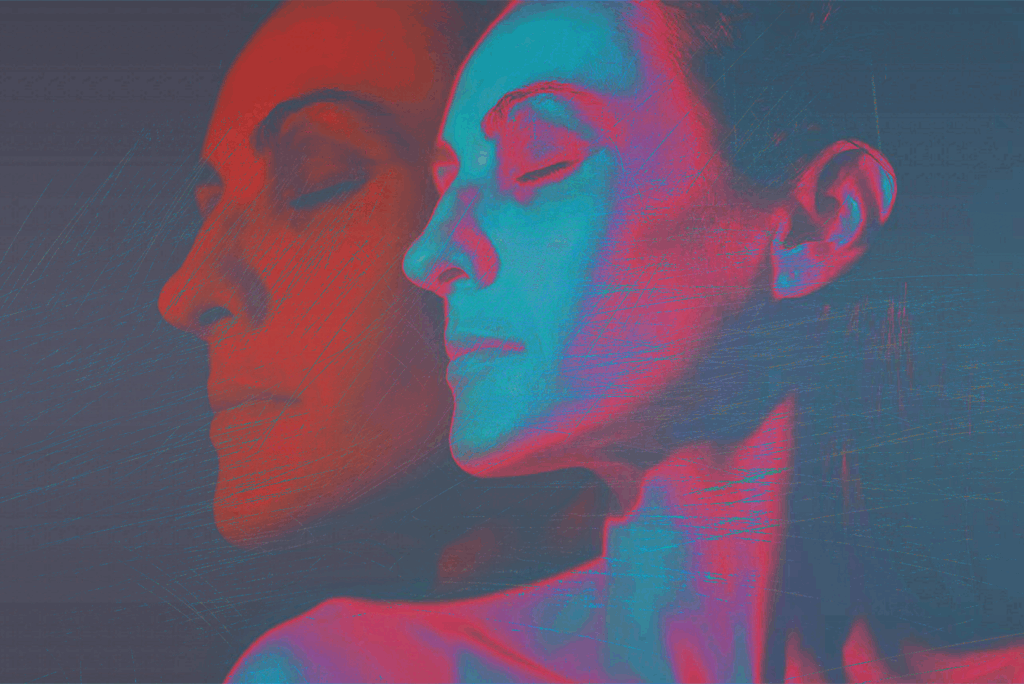Musica
Le isole non trovate nella canzone italiana
Una parziale disamina su terre, pirati e immaginari
A cura di
Giulio Bogani
☝🏻 Abbonati a Ratpark Magazine
☝🏻 Condividi se ti è piaciuto!
“Ma bella più di tutte l’Isola Non-Trovata:
quella che il Re di Spagna s’ebbe da suo cugino
il Re di Portogallo con firma suggellata
e bulla del Pontefice in gotico latino.”
Sono forse queste le parole migliori per iniziare un simile articolo, non tanto perché non ci sia altro esergo, ma perché nell’orecchio di chi l’ascolta arriva subito la voce arrotata di Francesco Guccini che, nel 1970, apre così il suo terzo 45 giri della carriera, appunto: “L’isola non trovata” con la canzone omonima, la quale a sua volta altro non è che una citazione un po’ scolastica e un po’ dotta, dell’incipit della poesia di Guido Gozzano “la più bella”, a cui il cantautore tosco-emiliano rende omaggio. E forse l’Appennino tanto caro a Guccini – che ad oggi è tornato a trascorrere la vecchiaia nella sua natia Pavana – è quanto di più lontano da un’isola possiamo trovare nella nostra tradizione. Eppure…
Eppure quello di Guccini è forse il destino di tanti di questa nazione, che nascono terrestri e arroccati nell’entroterra eppure si proiettano sul mare, con le sue fantasie e i suoi miraggi. Lo stesso Gozzano è piemontese: la sua riva potrebbe essere quella ligure, anche se si stenta a pensare un torinese come un uomo di mare. Ma è un dato di fatto che tanto Guccini quanto Gozzano subiscano il fascino della navigazione verso un orizzonte marino.
A questo punto possiamo divertirci a indagare se quelli sopracitati siano, appunto, casi isolati – scusate il gioco di parole – o se invece trovino buona compagnia: quanto contano le isole nella canzone italiana? E ancora: si sa che per fare ricerca bisogna andare all’origine, da dove viene allora tutto questo fantasticare?
Innanzitutto possiamo dare quasi per certo che, in mancanza di Harry Potter, Gozzano e Guccini si siano imbattuti da ragazzi in quel pilastro della letteratura su cui andiamo per forza a incagliarci parlando di isole, ossia: “L’isola del tesoro”, libro pubblicato da Robert Louis Stevenson nel 1883 – lo stesso anno in cui nasceva Gozzano a Torino -. Stevenson ha scritto un caposaldo che ha contribuito a creare quell’immaginario da filibusta a cui a tutt’oggi attingiamo a piene mani, si pensi per esempio alla fortunata epopea di Jack Sparrow e dei Pirati dei Caraibi, commentata musicalmente dal tedesco, naturalizzato americano, Hans Zimmer, vincitori con altre colonne sonore di diversi premi.
E se è grazie a Stevenson che è impossibile trattare di isole senza parlare anche di pirati, è è pur vero che anche in Italia c’è chi ha voluto fare la sua parte creando personaggi propri. In altre parole forse Long John Silver ci piaceva troppo o forse non ci sembrava abbastanza, così in Italia ci siamo spinti oltre e di pirati ne abbiamo voluti creare di nostrani, mostrando di nuovo il fascino che subiamo per il mare.
Penso ovviamente a Emilio Salgari, col suo Sandokan e con la sua Mompracem, e al gentiluomo di fortuna per eccellenza: Corto Maltese di Hugo Pratt – di cui riparleremo a breve. Non è forse un caso comunque che Pratt abbia illustrato anch’egli “L’isola del tesoro” e stesse disegnando un volume su Sandokan poco prima di dedicarsi a “Una ballata del mare salato” e inventare l’isola di Escondia.
Ad ogni modo, l’universo salgariano è chiaramente un riferimento essenziale per diverse generazioni di autori musicali, e non penso solo al classico brano “Sandokan” degli Oliver Onions, che risuonava come sigla nelle afose sere d’estate quando ero bambino, mentre la Rai (ri)trasmetteva l’omonimo sceneggiato del 1976 con Kabir Bedi nelle vesti dell’eroe, Adolfo Celi a interpretare il malvagio James Brooke e infine una splendida Carole André a fare la perla di Labuan.
Il brano musicale che introduceva la serie TV è divenuto talmente celebre da essere citato da Elio e le Storie Tese ne “il Pippero” quando Elio chiede ai bulgari se vogliano “qualcosa degli Oliver Onions… tipo Sandokan”. Pensando a Sandokan si deve citare anche compositori contemporanei, affascinati dall’epopea salgariana: mi riferisco ai Calibro 35, il cui brano orientaleggiante “Mompracem” è tra i più riusciti del loro ultimo album Nouvelles Aventures del 2023, un disco in realtà ispirato all’immaginario di un altro grande narratore di isole misteriose: Jules Verne.
Infine il nome di Sandokan risuona anche in una ballata celebrativa della Resistenza con “e io ero Sandokan”: ballata molto montanara e assai poco marinara che fa da tema musicale per il film “C’eravamo tanto amati” (1974) di Ettore Scola, scritta dallo stesso Scola e musicata da Armando Trovajoli – e poi reinterpretata più di recente anche dalla Banda Bassotti e da le Radici nel Cemento.
Ma l’idea di un’isola fantastica a cui dedicare scritti e canzoni non si esaurisce qua, in un continuo gioco di immaginari, rimandi e citazioni: ed è quindi opportuno ripartire dalla fantasia di James Matthew Barrie, il quale è quasi sicuramente influenzato dai suddetti Verne e Stevenson quando scrive il suo: “Peter Pan nei Giardini di Kensington” uscito nel 1906.
In Peter Pan lo scrittore inglese inscena l’ambientazione su Neverland, ossia un’isola, originariamente situata al centro del parco di Kensington e poi trasposta nella fantasia italiana col nome di “Isola che non c’è”: “seconda stella a destra, questo è il cammino”, ed è già Edoardo Bennato che di Peter Pan si innamora e al Capitano Uncino dedica un rock tutto suo (non ci soffermeremo invece per evidenti motivi sul discutibile ritornello dell’estate 2003: “muovi a tempo il bacino, sono il Capitano Uncino” di Francesco Facchinetti – alias Dj Francesco figlio d’arte di Camillo “Roby” Facchinetti dei Pooh).
Siamo in realtà di fronte a un arcipelago di personaggi, isole e luoghi immagini. Un’abitudine, questa di immaginare terre fantastiche, che viene da molto lontano: ne parla Umberto Eco nel suo: “Storia delle terre e dei luoghi leggendari” (Bompiani, 2013). Tra queste terre il nostro annovera il continente perduto di Mu e l’isola Ultima Thule, luoghi che, come vedremo, hanno ancora a che fare con la musica.
La prima in maniera indiretta, Eco cita infatti Mu e Corto Maltese che la ricerca in una delle sue ultime avventure: il marinaio di carta è molto musicale e si muove in tutta la sua carriera tra tanghi, ballate e canzoni di vario genere che Pratt non esita a citare e a riportare su carta. Lo spazio bianco del fumetto ha preso quindi voce attraverso: “Note di Viaggio – Le Musiche di Corto Maltese” un cofanetto di tre CD edito dalla Rizzoli/Lizard (2009) che contiene le tracce delle canzoni che accompagno Corto lungo le sue peripezie. Non facilissima da reperire, l’edizione è una preziosa raccolta di canzoni rare e per la maggior parte sconosciute o a rischio di essere dimenticate.
Ma, come già detto, non sono solo Corto e Mu a interessare Umberto Eco, ma pure l’Ultima Thule, da molti identificata nell’odierna Islanda: un’isola mitica che ha trovato il suo posto nella canzone italiana, di nuovo attraverso le parole di Guccini, il quale di mari non sembra saziarsi intitolando proprio “L’ultima Thule” il suo album del 2012 che reca in copertina una foto dell’esploratore e fotografo pistoiese Luca Bracali.
Sempre Guccini ha dedicato a Ulisse la canzone “Odysseus”, del 2004, perché in fondo quella dell’eroe greco è la storia per eccellenza che narra il vagare e perdersi per isole – e per donne! Ulisse è il peggiore capitano del mito – come ci indica chiaramente Lucio Dalla nella commovente “Itaca”, canzone scritta alle Isole Tremiti e uscita nel 1971 – e infatti nessuno dell’equipaggio dell’eroe si salverà, ma ci viene presentato ora da Guccini come un avido scopritore di genti e terre, un esploratore curioso, di memoria quasi dantesca.
E se vogliamo guardar bene e alzare il velo, le donne a cui Ulisse si accompagna nel viaggio di ritorno sono tante e corrispondono tutte a isole diverse, dunque per citare Thomas Merton “nessun uomo è un isola”, ma cosa dire delle donne? Donne e isole sono indissolubilmente legate nell’immaginario e forse allora il navigante altro non è che un libertino.
Ma in fondo la lussuria, cos’ altro è se non passione per la conoscenza? Questo lo illustra bene il filosofo Giulio Giorello che intitola infatti così il suo libro in merito: “Lussuria, la passione della conoscenza” uscito per il Mulino nel 2009. E non è forse intorno a un’isola, nei mari di Escondia, che anche Corto Maltese incontra Pandora Groonvensore? Un rapporto quello tra donne e mare glorificato anche da Mannarino “quanto è bbono l’odore dell’onda” nella romanissima “Me son’mbriacato” del 2009. Sempre da Roma arriva invece “La paranza” dove l’isola di Ponza è il rimedio indicato da Daniele Silvestri per ogni delusione amorosa provocata da una “stronza” (il brano viene cantato al Festival di Sanremo, nel 2007).
L’isola, immaginaria o meno, quindi è anche tessitura d’ amore e a volte non solo in termini narrativi ma anche biografici. Così è stato per l’altro grande della musica italiana, ossia Fabrizio De André, che va per forza citato parlando di isole: il Faber genovese trova nella Sardegna la terra d’elezione. Come è noto, vi rimedierà anche un’esperienza di rapimento, raccontata splendidamente nella canzone “Hotel Supramonte” dell’omonimo disco del 1981, ma nonostante ciò non si separerà mai dall’isola dei nuraghe ed infatti è lì, a Tempio Pausania, che otto anni dopo, nel 1989, sposerà Dori Ghezzi.
E se la terra sarda ispira e commuove il cantautore genovese, è invece un’altra isola che muove infine diverse voci del cantautorato italiano a cavallo tra la seconda metà degli anni ‘80 e i primi anni ‘90: l’Irlanda, che è presente non solo ne “gli amanti d’Irlanda” di Ivano Fossati del 1986 e ne “il cielo d’Irlanda” scritta da Massimo Bubola e interpretata da Fiorella Mannoia nel 1992, ma è vera e propria ispirazione per i Modena City Ramblers che, dalla bassa padana, dedicano all’isola verde il loro pezzo più rappresentativo “In un giorno di pioggia” (1994) oltre che altre ballate tra cui la splendida “Canzone della fine del mondo” che, fino ad allora inedita, appare per la prima volta nel disco “Live Acustico al Sisten Irish Pub” del 1998.
E i giorni nostri invece? Beh è doveroso citare e chiudere con Lucio Corsi, maremmano doc, che per spiegare come siano fatte le conchiglie attinge alle isole dell’arcipelago toscano in una poetica “Cosa faremo da grandi” dell’album omonimo del 2020: “Probabilmente sono state fatte a mano / Da un uomo sull’Isola d’Elba / C’ha lavorato una vita e poi / S’è stufato e le ha tirate per terra”.
Sicuramente ci sono canzoni ed isole che ho tralasciato o che non conosco ancora, e sarò lieto se me le vorrete indicare così che io le possa visitare, ma dopo questa lunga disamina, non rimane che appoggiare l’orecchio a una bianca conchiglia e mettersi ad ascoltare.