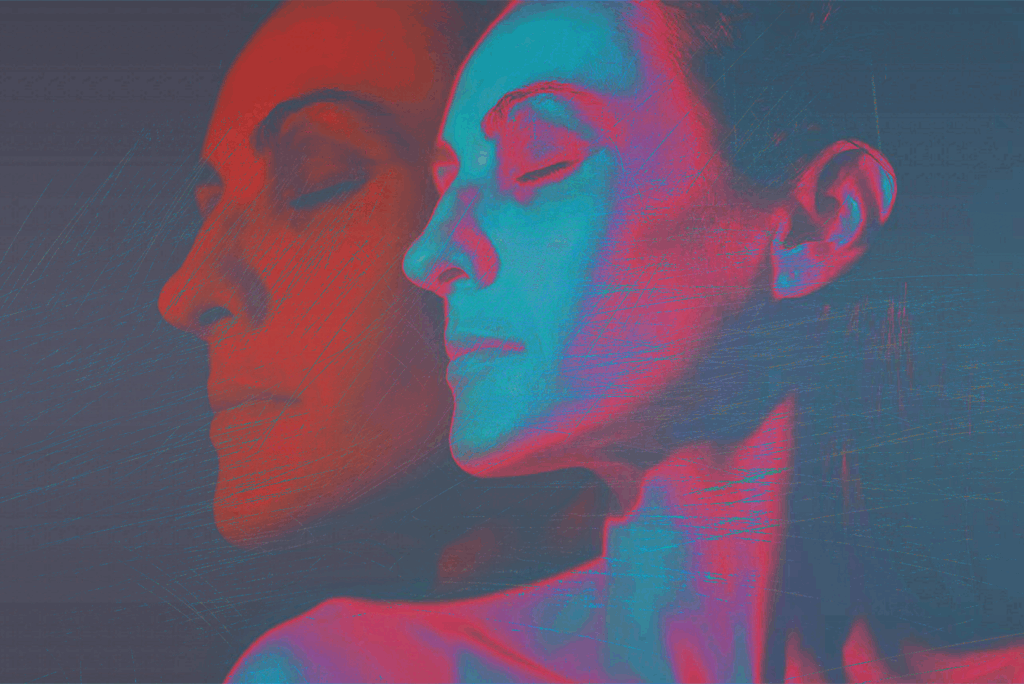Arte
L’arte dell’inganno e l’inganno dell’arte
Tre storie per raccontarlo
Voglio raccontarvi solo tre storie, come disse Steve Jobs nel suo discorso agli studenti di Stanford: “that’s it. No big deal. Just three stories”. Ma qui, anche se si guarda sempre al mitopoietico mondo anglofono, siamo in Italia e quindi: “solo tre storie”.
La prima storia
La prima inizia nel 2013: siamo nel Meridione, dalle parti di Cosenza, e in casa c’è un padre che deve guardare suo figlio, ma siccome il pargolo è calmo e il tempo tende alla noia, il giovane genitore, che chiameremo Fabio Nirta, decide di accendere il computer e di provare a remixare quegli spezzoni di canzoni che i Daft Punk hanno rilasciato prima di lanciare “Get Lucky”, il singolo che fa da anteprima del loro album in uscita “Random Access Memories”.
Il diversivo creativo dura una mezz’oretta o poco più: il tempo per Nirta di caricare il brano “fake” su Youtube con un link Sendspace per il download e lasciarlo là mezza giornata. La canzone diventa virale, viene presa per una release reale, fanbase in delirio e pezzo fin troppo simile all’originale (complimenti a Nirta che continua a fare il Dj e ha creato nel frattempo anche Bizarre Love Triangles, agenzia di PR e management di artisti nostrani).
Una seconda storia “italiana”
La seconda delle nostre storie si dipana su un tempo un po’ più dilatato, ma trova al suo centro di nuovo un fan italiano, di nome Fernando Nuti (dei New Candys), che rimette insieme un accenno di brano degli Strokes: pochi secondi di canzone usciti a commento musicale della pubblicità di un profumo, ma quei pochi secondi gli bastano per creare un’intera canzone piuttosto credibile: “I like the night” da oltre 3 milioni di visualizzazioni. Questa storia finisce diversi anni dopo, con il frontman della band newyorkese, Julian Casablancas, che interpellato in merito all’operazione, dice all’autore a fine di un concerto “it’s ok man”. Come dire: “m’importa il giusto, tutto a posto”.
Prendiamoci un po’ di tempo per riflettere su tutto questo e poi vi racconto la terza storia, ma prima appunto poniamoci una domanda: “è stata tutta una truffa?”. Sia Fabio che Fernando nelle loro azioni e nelle loro dichiarazioni hanno dimostrato che la loro prima preoccupazione era quella di non offendere i loro beniamini e non avevano intenzione di plagiare il pubblico, né tantomeno arricchirsi.
Quindi, in mancanza di dolo e di profitto personale, la risposta è senz’altro no, non la possiamo affatto considerare una truffa, ma semmai un espressione del genio che gioca sul quel labile confine che separa la realtà dall’immaginazione del possibile, se non del probabile. Il fatto è che queste due storie ci mostrano come la linea che separa vero e falso, fatto e mito è molto più sfumata di quanto non pensiamo, nella storia in generale e nell’arte in particolare.
Si pensi per esempio alla celeberrima burla del 1984, quando tre studenti universitari livornesi: Michele Ghelarducci, Pietro Luridiana e Pierfrancesco Ferrucci, trassero in inganno l’intero gotha della storia dell’arte italiana – tra cui Giulio Carlo Argan e Carlo Ludovico Ragghianti – facendo passare per attribuibile a Modì una testa scolpita dal suddetto trio con un Black &; Decker, tranne poi rivelare la farsa in diretta TV ridicolizzando l’arcigna critica italiana pronta a giurare e spergiurare che quelle fossero opere originali del maestro labronico, come altre due ripescate in quei giorni e scolpite per provocazione da un giovane artista labronico, Angelo Froglia. E se tutto questo è successo nella storia dell’arte, perché allora la musica dovrebbe fare eccezione?
Non si dice nulla di nuovo a dichiarare che la musica è una fornace di miti contemporanei, di idoli da top streaming, di star delle emozioni; la musica muove i sogni delle masse e conseguentemente affari di massa (il riferimento è al recente fenomeno della cosiddetta “Swift economy” – che poi che c’avrà mai Taylor Swift? N.d.R.).
Ma tutto questo baraccone di sogni (“siam quelli là, quelli tra sogni e realtà” cit. Ligabue) ha bisogno di un complesso impianto di immaginari per sopravvivere, ha bisogno in altre parole del fatto che noi amanti della musica ci appassioniamo a una mitologia, ossia il jet-set, in cui i nostri eroi, ossia i cantanti e musicisti, si muovono come in un teatrino ad uso e consumo del pubblico: è il caso per esempio della lucrosissima reunion dei fratelli Gallagher.
E tutto questo non ci crea alcuno sconcerto, al contrario, ci piace. Esattamente l’opposto di quanto avviene ne “il Fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello, quando si pone la domanda: “ Se (…) si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe?”. Un terribile sconcerto è la risposta che lo scrittore siciliano mette in bocca ad Anselmo Paleari.
Noi lo sappiamo fin troppo bene che il cielo dello star-system è di carta e che ancora di più lo sono quelle parole che si spendono ogni giorno sulle nostre radio per incensare una scena rock varia e variopinta – e diciamocelo ormai anche un po’ appassita e ripetitiva.
E pur tuttavia, come falene esposte alla luce, ne siamo affascinati e in fondo non ci importa troppo cos’ è vero e cosa no. La truffa, esattamente come la burla, altro non fa che rompere il palcoscenico, ossia mostrare la nudità dei re per riderne un po’ insieme e serve per elevare dei comuni mortali a improvvisate stelle di un pubblico che ne apprezza la sregolatezza e il genio (definito come da tradizione: “fantasia, intuizione, colpo d’occhio e rapidità d’esecuzione”).
Ora non so se vi sia capitato di vedere una piccola docuserie su Disney+ che si chiama Camden, la quale racconta, cito: “le storie inedite di vita e carriera di alcuni degli artisti più iconici del mondo che sono stata influenzate da questo angolo di Londra”. Dagli Oasis a Amy Winehouse, passando per i Libertines di Pete Doherty, l’intero documentario si inserisce perfettamente, sin dalla descrizione, nella scia di quanto detto finora: mitizzazione e subculture con storie che, da piccole e marginali, diventano simboliche e cariche di significato – musicale e personale – per intere generazioni.
Il mondo della moda tutto ciò lo sa benissimo, poiché se ne nutre da anni proprio come un attento vampiro si ciba del sangue delle sue succose prede. Il capitalismo più bieco che sta dietro a ogni grande brand (il riferimento a Bernard Arnault e François Pinault è del tutto intenzionale) si foraggia di significati e inconsci collettivi interpretati dalla musica e puntualmente saccheggiati dal fashion: nel migliore dei casi l’intenzione è anche genuina e possiamo concedere il beneficio del dubbio al reale intento di Vivienne Westwood, supponendo che non abbia fatto ciò che ha fatto solo scarnificare e spolpare di significati gli ambienti musicali di cui lei stessa è stata indubbia protagonista.
Tuttavia da buon millennial quale sono, l’ultimo fenomeno e mito rock per me rilevante in questo senso è stato appunto l’indie-sleaze, incarnato dalla toxic-couple Pete Doherty e Kate Moss e immortalato da Hedi Slimane, quest’ultimo famoso più per essere un celeberrimo direttore creativo delle maison di Parigi (Dior, YSL, Celine tra gli altri) che per essere l’autore di un intero libro fotografico a tema Doherty dal nome evocativo: “London, birth of a cult”. Lo stesso Slimane ha poi fatto posare Julian Casablancas come testimonial per Celine Homme nel 2023 – con dubbi risultati a dire il vero.
L’ultima storia, quella di Giulio
Questo inciso ci serve per introdurre la terza storia che parla di resistenza e che, come le migliori resistenze, nasce dalla voglia di ridere. Era un qualche pomeriggio di primavera del 2023 quando, mentre commentavamo l’ultimo singolo uscito dalla premiata ditta “Daft Punk-Casablancas” Infinity Repeating (carino, niente a che vedere con Instant Crush), con un’amica venne l’idea di immaginare come sarebbe stato un concerto dei Daft Punk a Poppi, o a Montaione o in qualche sperduto paesino toscano.

E come sarebbe stato, se per un attimo invece dei bar di New York o di Camden ci fossero state le vigne del Chianti? E proprio mentre l’AI veniva usata per far uscire una cover di Frank Sinatra che cantava Smell Like Teen Spirit e le immagini di Papa Francesco che sfilava con un Moncler, perché allora non inventare con gli stessi strumenti un reportage di un evento che non c’era mai stato, ma che sarebbe stato molto divertente pensare che fosse esistito?
Perché non portare i miti in terra (toscana) e divertirsi a immaginare le nostre feste provinciali e un po’ fricchettone frequentate da cotanto jet-set? E chi ne potrebbe immortalare le pose se non una fantomatica fotografa fiorentina, snob e altolocata dalle iniziali A.I.: Alicedora Isoldi (Alice, che nel paese delle meraviglie, appunto, adora i soldi)?

Ne è nato un piccolo progetto di riappropriazione nostrana dei miti, certo meno brillante magari di quanto fatto da altri, ma nella stessa scia, dove si è voluto anche dare vita a vere proprie band del sottobosco musicale internazionale che semplicemente non sono mai esistite, ma i cui nomi e album sono possibili, se non probabili: ecco allora arrivare Gli Electroad, i Les Ateliers, e cantautori Richard Sorge (rimando al podcast di Alessandro Barbero per scoprire chi fu davvero Richard Sorge e di come la sua esistenza tra vero e falso, tra truffa e realtà, abbia cambiato i destini del secondo conflitto mondiale).

E quindi come evitare la tentazione di rappresentarne anche le copertine degli album? E così siamo di fronte a un piccolo ma plausibilissimo nuovo falso, che allo stesso tempo è una truffa e un omaggio, ma prima di tutto una risata beffarda a chi i nostri miti e le nostre canzoni ce li vuole per forza commercializzare in un brand di lusso. E in fondo anche questa è una storia di resistenza. A dir la verità poi la fantasia ha toccato la realtà quando l’anno scorso Jovanotti ha portato Rick Rubin a Casole D’Elsa per il Festival of the Sun, durante il solstizio d’estate. Ma questa, come si dice, è un’altra storia.