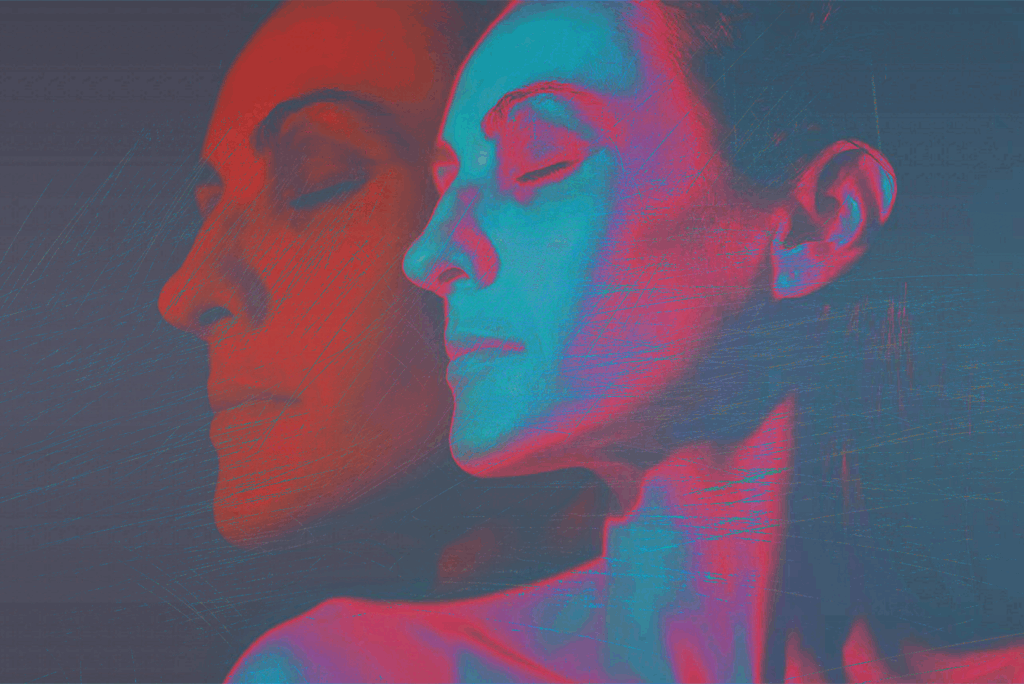Cinema
Parthenope e il mistero della seduzione
Miracolo o inganno?
Tratto dalla rivista N.08
A cura di
Pierfrancesco Quarta
☝🏻 Abbonati a Ratpark Magazine
☝🏻 Condividi se ti è piaciuto!
Compaiono i titoli di testa: la scritta Parthenope campeggia sul grande schermo. Il Golfo di Napoli sullo sfondo.
Stacco.
Da sotto al mare affiora Parthenope.
Stacco.
Vedendola, Sandrino, bacia il crocefisso che ha intorno al collo.
Stacco.
Lei procede come una sirena, ma mentre cammina si toglie qualcosa da sotto un piede. Lui subito la definisce «una diva».
Stacco. I titoli di testa si concludono con scene di seduzione fra i porticati di Napoli.
Così si apre l’ultimo lavoro di Paolo Sorrentino, Parthenope, dopo una breve premessa, nella quale ci viene presentata la nascita del personaggio eponimo, interpretato dalla bellissima e sensuale Celeste Dalla Porta. Da subito capiamo, quindi, due cose. Uno: il nome Parthenope, ricevuto dal padrino, è un nome parlante che ha come riferimento Napoli. Due: il film è un film sulla seduzione.
Questo appare chiaro fin dalle primissime scene, in cui Parthenope raggiunge l’età della bellezza al suo culmine. Via, via, la vediamo sedurre involontariamente chiunque la incontri. Si ferma persino chi la vede da lontano. Un gruppo di canottieri sotto il suo balcone, un riccone in elicottero. Molti uomini accompagnati.
Lei, Parthenope, sempre sulla bocca di tutti come una Venere nata dalle acque, che esercita il suo charme in particolar modo sulle persone vicine a lei. Come Sandrino, figlio della governante e amico di suo fratello, Raimondo, prima vittima del suo potere.
Ma il film è un film sul potere della seduzione, come La Favorita di Lanthimos, o sul suo mistero, come La Dolce Vita di Fellini? La risposta ce la dà il dialogo tra la protagonista e Flora Malva, sua prima insegnante di recitazione. Da qui lei imparerà, col tempo, a non puntare tanto sulla propria bellezza, quanto sull’ambiguità e sul mistero.
La seduzione che la sfigurata Flora Malva mette in atto nel vapore del suo bagno gioca proprio con la curiosità suscitata dal mistero. Ma il fatto che l’allieva ceda alle avances della sua maestra, dimostra che ancora la lezione non è stata appresa. Ci vorrà del tempo prima che Parthenope impari a non usare la sua bellezza per fare carriera.
Parthenope oscilla tra ambiguità e bellezza per farsi aprire tutte le porte, ma quello che queste porte nascondono è quasi sempre un inganno. L’unico miracolo nascosto dietro una di queste, in casa del professore, è mostruoso e deforme, ma Parthenope è felice lo stesso. Piange, perché ha capito che il vero miracolo non sta necessariamente nella perfezione.
Prima, durante tutto il resto del film, per presentare sé stessa come un miracolo, Parthenope aveva usato esclusivamente l’arma della seduzione, anche a costo di indossare i pesanti gioielli di San Gennaro per avvicinarsi a Dio nel più profano dei modi. Solo dopo quella scena, invece, riesce a cogliere il suo stesso inganno.
In mancanza di questa chiave di lettura lo spettatore potrebbe smarrirsi di fronte alla mole di avvenimenti sconnessi fra loro che avvengono nella travagliata vita della protagonista.
Dopo amori sbagliati, scelte di vita tradite, una gravidanza interrotta e il grande rimpianto a cui pensa ogni volta che le domandano «A che cosa stai pensando?», è difficile seguire la coerenza della narrazione.
Sorrentino ci ha abituati a uno stile di montaggio centripeto, già dai tempi del suo Oscar, con film come la Grande Bellezza e Youth, anch’essi parte della stessa fase stilistica e basati in qualche modo sulla seduzione, ma che, più nel dettaglio, parlano della bellezza di Roma e dell’ideale di giovinezza.
Ma, pur all’interno della medesima fase creativa, È Stata La Mano Di Dio e Parthenope hanno, invece, diviso il pubblico. “Perché?”, viene da chiedersi. Perché è volutamente sfaccettata la lettura che se ne può dare: perché è il regista stesso, a richiedere uno sforzo d’interpretazione da parte dei suoi spettatori.
Senza spingersi al livello di ermetismo dell’allegorica dantesca, presente, ad esempio, in un anime come Il Ragazzo e l’Airone (Hayao Miyazaki, 2023), Sorrentino sfiora a più riprese un certo livello di complessità simbolica.
Al contrario di alcuni eventi storici come l’avvento del colera, la crudele unione fra due famiglie camorriste e lo scudetto del Napoli, che sono mostrati chiaramente sulla scena, alcuni degli eventi che hanno luogo all’interno della narrazione, presentano invece un forte valore simbolico. Fra questi, possiamo citare il potere premonitore dei tuffi all’indietro di un «bellissimo e infelice» Raimondo, ma anche il rapporto dogmatico con l’antropologia, il ragazzo di acqua e sale, l’amplesso col vescovo all’interno della cattedrale, e così via. Per trovare la chiave di lettura giusta, occorre dunque partire dalle basi: che valore ha il giudizio del pubblico?
Parlando con varie persone, all’uscita della sala e nelle settimane successive, ho avuto modo di ascoltare le risposte più disparate. “Una vita tristissima”, “Un’altra banale metafora di Napoli”, “Il personaggio di Silvio Orlando: numero uno!”, “Ha provato a rifare La Grande Bellezza”; “Un’accozzaglia di eventi sconnessi”, “Un porno malato”, sono solo alcuni dei giudizi (poco imparziali, ma al contempo altrettanto validi), che ho avuto modo di captare.
Per farvi capire il livello di validità accordabile a un’interpretazione qualsiasi, io stesso ho azzardato un’ipotesi talmente assurda e volutamente grottesca, da rendere quantomeno l’idea di quanto la trama sia malleabile alle deformazioni dell’interprete: il film è l’opposto speculare della trama di Spiderman 2 (quello bello, di Sam Raimi). Fateci caso: una ragazza scopre di avere dei poteri inebrianti, che però confliggono con la sua vita privata, così decide di dedicarsi agli studi universitari; ma anziché riprendere il costume da supereroe, nel finale di Parthenope assistiamo alla sua scalata accademica, in seguito alla scelta della protagonista di mettere da parte ciò che per tutta la vita l’ha perseguitata. Ma qual è, dunque, questo super-potere, se non quello della seduzione?
La scena in cui lo scrittore John Cheever, interpretato da un magistrale Gary Oldman – incredibilmente nello stesso cast di Biagio Izzo, in un film distribuito da A24 (se non è una truffa questa…), – rivela a Parthenope che la sua bellezza può aprirle ogni porta, ricorda il momento in cui Peter scopre di riuscire ad arrampicarsi sui muri.
Stacco. Lei si trova lì, davanti a uno specchio, con un velo addosso e una sigaretta fra le dita. Rapita da sé stessa, Parthenope indietreggia e nota un ragazzino al di là della vetrata della stanza. Lei lascia cadere il velo da sopra il suo seno; così, lui le offre un fiore. Questo passaggio è come quello in cui Peter Parker lancia la sua prima ragnatela, all’interno del primo film; lo stesso in cui lo zio Ben pronuncia la celeberrima frase «Da grandi poteri derivano grandi responsabilità».
E Parthenope impara subito questa amara lezione, nel modo peggiore possibile: una notte di follia e di amore, una caduta dalla scogliera. Una scelta deliberata di suo fratello, dalla quale la nostra protagonista non si riprenderà mai. «A che cosa stai pensando?», è la formula che ci catapulta sempre in un frame tra i Faraglioni di Capri.
È per questo motivo, dunque, che Parthenope sceglie prima di iscriversi all’Università e poi, col tempo, di seguire il consiglio di Flora Malva. Il suo potere è anche un pericolo e più il tempo passa, più lei se ne accorge.
Esattamente come Spiderman 2 non è un film sull’Uomo-Ragno, ma su un ragazzo, Peter Parker, combattuto fra i suoi obblighi morali (difendere la popolazione) e le sue esigenze personali (la passione per lo studio e l’amore per Mary Jane), anche Parthenope non è un film sulla donna/Napoli, ma sul rapporto che il regista ha con la sua città natale, combattuto com’è fra la fascinazione per il suo mistero e il timore che dietro al miracolo si celi un inganno.
Il rapporto fra mistero e realtà si declina dunque, in una simmetria perfetta fra miracolo e truffa. L’arte dell’inganno è essa stessa seduzione. Possiamo cogliere questo aspetto fondamentale in una delle primissime scene, in cui Sandrino contempla estasiato una giovane, nuda Parthenope, all’interno della carrozza settecentesca il cui arrivo apre il film e che da subito pone il dubbio: prodigio venuto da Versailles o truffa alla napoletana?
Il fulcro del racconto è tutto qui: Sandrino non può accedere all’interno della carrozza, è costretto a osservare da fuori il mistero che contiene, il corpo della diva Parthenope, che guarda lui e noi, con aria divertita.
Lo sta ammaliando? Lo sta ingannando? Potremmo dire entrambe le cose insieme: lo sta seducendo.
Ma potremmo spingerci anche oltre e chiederci se al di là del puro fascino non ci sia di più in ballo. Il momento in cui il vescovo Tesorone dichiara di essere ritenuto responsabile della liquefazione del sangue di San Gennaro non rappresenta esso stesso la dicotomia tra miracolo e truffa?
E la Mano de Dios, che cos’è? Un miracolo o una truffa?
Se È Stata La Mano Di Dio propende per la prima risposta, Parthenope chiude un dittico in senso opposto. Non è un caso se il film si conclude con la vittoria del terzo scudetto del Napoli.
La figura di Maradona è la perfetta esemplificazione di questo rapporto che il regista sente con la propria città e che sfocia nell’intenso monologo di Greta Cool sui napoletani. Il vero napoletano fugge dalla città del miracolo, Napoli accasciata sotto un vulcano attivo; perché Napoli è anche la città della truffa. Lo sa Greta Cool, ma lo sanno anche Sorrentino e il personaggio di Stefania Sandrelli (scelta di casting di scoliana memoria, strabiliante da quanto è azzeccata).
All’interno del film, infine, è solo uno il personaggio che si rende conto dell’inganno perpetrato dalla protagonista, al fine di tenere alta la curiosità su di lei e sul suo aspetto divino: è il milionario che segue la dea Parthenope a Capri dal suo elicottero. Solo lui, dopo essere stato respinto, si renderà conto del modo di fare della protagonista. I suoi sguardi languidi, il suo pallino per la battuta pronta: sono tutti schemi che mette in atto per sedurre, per nascondere il miracolo dietro una coltre di mistero, quando tutto, in realtà, è soltanto una bella truffa.