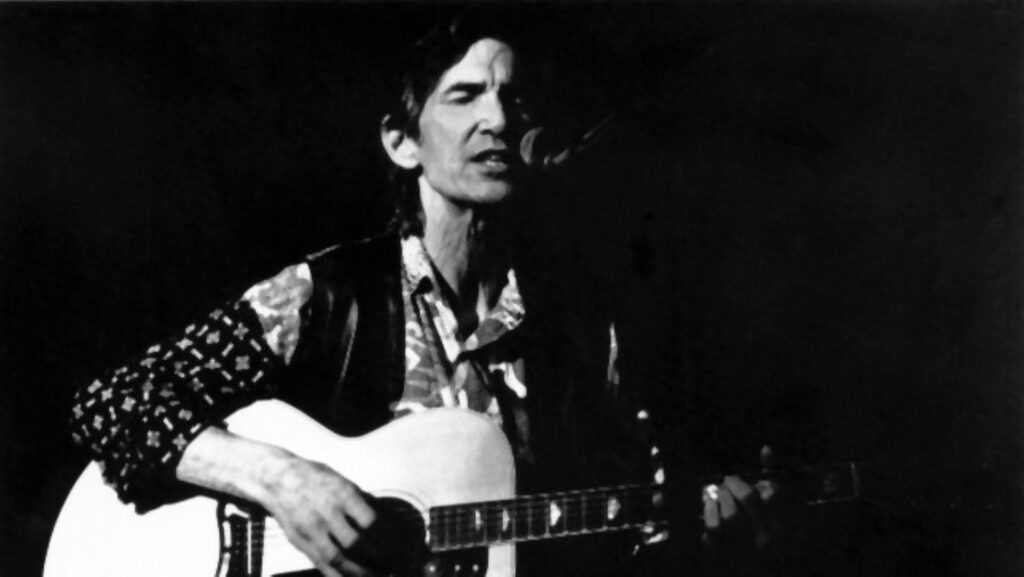Cinema
Aftersun e Paternal Leave: storie di padri e figlie
Uno sguardo femminile sulla fragilità maschile
A cura di
Immagine di
Francesca Romito
☝🏻 Abbonati a Ratpark Magazine
☝🏻 Condividi se ti è piaciuto!
Nel 2022 Charlotte Wells, cineasta scozzese, firma il suo esordio alla regia con Aftersun, un film in cui, cedendo velatamente all’autobiografismo, racconta la vacanza estiva in Turchia tra un giovane padre, Calum (Paul Mescal) e una figlia adolescente, Sophie (Frankie Corio).
Tre anni dopo, nel 2025, esce al cinema Paternal Leave, un altro esordio cinematografico dell’attrice e regista tedesca Alissa Jung. Anche lei sceglie di indagare il rapporto tra un padre e una figlia. Leo (Juli Grabenhenrich) è una quindicenne berlinese ostinata ad incontrare il padre Paolo (Luca Marinelli), un insegnante di surf riminese, sparito prima che lei nascesse.

In un tempo relativamente breve, il cinema ha regalato al suo pubblico due occasioni per riflettere su un tema che, se può considerarsi ampiamente affrontato e dibattuto al maschile, costituisce un territorio sconosciuto e scivoloso quando a parlarne è una donna: il rapporto tra padre e figlia.
Infatti, per poter scovare un titolo che abbia al centro questa tematica, bisogna tornare indietro negli anni, fino al 2009, quando Sofia Coppola raggiunse le sale cinematografiche con Somewhere.
Pochissime altre voci si sono alzate sull’argomento.
Se invece si cercano firme maschili, l’elenco è assai più lungo.
Ma volendo restringere il campo di ricerca e provando ad eliminare dai parametri la narrazione del padre forte, autoritario e normativo, di quanto si accorcerebbe la lista?
Oltre al tema, la vera rivoluzione all’interno di Paternal Leave e Aftersun è il modo in cui lo sguardo femminile indaga la fragilità maschile. La società ci ha abituati e, spesso, costretti a tenere categoricamente separati l’aggettivo fragile dal sostantivo uomo; perciò, la possibilità di una narrazione che rompa le catene delle convenzioni e racconti una storia sincera, è una liberazione che commuove chi dentro quei confini così rigidi e patriarcali si è sentito troppe volte oppresso e strappa un sorriso amaro a quelle figlie che avrebbero voluto liberare i loro padri dalla morsa del ruolo.

Si prenda American Beauty. Il film di Sam Mendes è l’esempio ideale a supporto del discorso appena proposto. In questa storia vengono introdotti due modelli di padre molto diversi tra loro. Da una parte vi è il protagonista, Lester Burnham, la cui inadeguatezza viene resa macchiettistica: è un uomo di mezza età, scontento della vita, disoccupato e svilito dalla moglie. Si invaghisce dell’amica minorenne della figlia e tutta la narrazione ruota intorno alle sue debolezze sessuali, ma poco si indaga la sua condizione mentale sull’orlo di un collasso.
Il secondo modello di padre, invece, è il cosiddetto padre padrone, qui rappresentato dal colonnello Frank Fitts, vicino di casa del protagonista. Violento nei confronti del figlio, gli impone regole rigide per temprarlo e renderlo un uomo virile e rispettato. Il risultato che ne ottiene è un ragazzo con evidenti problemi di emarginazione sociale e con tendenze voyeuristiche. Del padre, in conclusione, si scopre la natura omosessuale e quindi la repressione a cui negli anni si è sentito costretto a sottostare.
Questo è solo uno degli esempi disponibili nell’ampio catalogo cinematografico che affronta il tema, ma è ottimo per dimostrare come nonostante i pessimi risultati dovuti a modelli patriarcali così tossici e inefficaci, ci si ostini a pensare che il padre forte e incrollabile sia l’unica figura a cui affidarsi.
Ed ecco perché di personaggi come Calum e Paolo abbiamo bisogno. Le due registe sono state in grado di sovvertire la narrazione e mostrare gli esseri umani prima ancora dei loro ruoli e dei loro generi.
Addentriamoci in un’analisi più dettagliata dei due film, così che si possa meglio comprendere il lavoro di decostruzione che lo sguardo femminile è riuscito a fare sui protagonisti.
In Aftersun, Wells ha concentrato la sua narrazione su un’attenta costruzione dei livelli temporali della storia. Il tempo del racconto è il presente, che vede Sophie, presumibilmente all’età del padre ai tempi della vacanza, intenta a ricostruire, attraverso le immagini che le restano di quell’estate del ’90, una memoria che ai tempi, per la giovane età, ha fallito nel catturare i dettagli. Poi, c’è il tempo della storia, ovvero il viaggio stesso, nel momento in cui accade.
Il sottotesto di questa frammentazione fa supporre un interrogarsi incessante della figlia che, crescendo, cerca nel passato delle risposte alla scomparsa del padre. Seppur questo non venga mai esplicitamente detto all’interno del film, l’autrice lascia supporre che Calum si sia tolto la vita. È possibile che quella sia stata la loro ultima vacanza insieme. Da bambina, Sophie si era creata un’immagine del padre che poi, da adulta, ha dovuto inevitabilmente mutare.
Wells sembra voler suggerire che la memoria, così come i ricordi, la costruiamo e modelliamo a nostro piacimento e non sempre coincide con la realtà. E allora, la domanda che Sophie, ormai adulta, sembra porsi di fronte a quei ricordi analogici, potrebbe essere “Chi era davvero mio padre?” e soprattutto “Mi aveva dato segni della sua sofferenza?”.
In questo senso lo spettatore ha il privilegio di cogliere il profondo dolore che emerge dalla fragile figura di Calum, il quale sembra muoversi nel mondo come se avesse già scelto la resa all’azione, ma che ce la mette tutta per non fallire come padre e per fare in modo che la figlia conservi dei ricordi entusiasmanti di quell’estate.
La frammentazione non appartiene solo al tempo, ma anche all’immagine: come la regista racconta in alcune interviste rilasciate poco dopo l’uscita del film, spesso la figura dell’uomo è restituita al pubblico attraverso superfici trasparenti: il vetro di una finestra o di una cabina telefonica, l’obiettivo della videocamera, la superficie dell’acqua. A volte, addirittura, Calum è ripreso di spalle. Questo suggerisce l’inafferrabilità del padre, la fuggevolezza con cui la bambina si trova a fare i conti.
Lui piange. Ride. Si arrabbia. Fallisce. Si diverte. Soffre. Si sente inadeguato.
Eppure, c’è un eppure.
Nonostante tutte queste sfaccettature, anzi, forse proprio in virtù di queste, è un padre. Ed è una persona. Ciò che lo rende non solo umano, ma anche un personaggio memorabile non sono le imprese eroiche, ma il suo tentativo di aggrapparsi alla vita.
Se Wells ha concentrato il suo discorso sulla memoria che resta quando un padre scompare, la regista tedesca Jung parte da un altro interrogativo: cosa porta un uomo a rinnegare la propria paternità?
Paolo non ha mai conosciuto Leo e ha vissuto la sua vita come se la figlia non esistesse. Lei, con un quaderno in mano, sin dall’inizio cerca risposte urgenti. Perché non l’ha mai voluta conoscere? Come se la immaginava? Ha mai pensato a lei? Che nome le avrebbe dato?
Anche in Paternal Leave c’è un elemento che produce distanza e genera incomunicabilità tra i due personaggi: la differenza linguistica. Il padre, infatti, parla italiano, la figlia il tedesco. L’inglese è la lingua ponte che permette loro di provare a comprendersi, ma è solo il tempo a migliorare davvero la loro comunicazione. In quest’opera non sono i silenzi a regnare, ma anzi, la parola, parlata o urlata, anche quando non capita, è comunque lo strumento più utilizzato per conoscersi.
Il mare è l’ambientazione di entrambi i film, ma se la Turchia è rappresentata nel pieno del suo turismo estivo, la Rimini invernale è un paesaggio a parte, anzi, ci si potrebbe spingere a definirlo un non-luogo, un limbo in cui si attende e dove nulla sembra accadere. Quando la stagione calda finisce, Paolo rimane sospeso in un tempo che lo separa dall’anno successivo. Un immobilismo che gli è proprio, parte della sua naturale predisposizione all’inazione.
Dietro questa vita vissuta a singhiozzi, si nasconde una paura di esistere pienamente, di confrontarsi con la possibilità del fallimento. Il suo senso di inadeguatezza non ha solo a che fare con i confini dettati dal ruolo di padre, ma raccoglie un senso più ampio e totalizzante. Leo, con la sua incoscienza e anche grazie a quel fuoco di rabbia e delusione che le brucia dentro, riesce a strappargli prima un’ammissione di colpevolezza – Paolo le racconta di quando ha scoperto che sarebbe venuta al mondo, e dell’essersi sentito terrorizzato e inadatto ad assumersi quella responsabilità – e poi il desiderio di costruire insieme il rapporto che la sua assenza ha impedito di creare negli anni.
Anche in questo caso, le fragilità umane emergono senza troppe reticenze e l’unico timore reale non è quello di dimostrarsi deboli, ma quello di perdersi reciprocamente, di nuovo.
Entrambi questi padri, seppur intrappolati nelle loro sovrastrutture, fanno prevalere la legge dell’amore sulla legge della forza. Sono pronti a mettersi in discussione e a confrontarsi sui loro passi falsi. Le loro figlie diventano uno specchio in cui guardarsi per vedere in cosa potrebbero migliorarsi. Davanti a queste due opere, lo stesso pensiero mi ha attraversata a distanza di un paio d’anni: se le generazioni venute prima di noi fossero state in grado di decostruirsi, se avessero lavorato sulla comunicazione e sulla demistificazione della fragilità, invece che su potere e gerarchie, probabilmente ad oggi il mondo sarebbe abitato da persone capaci di reagire al fallimento non con violenza, ma con serenità.
Lo aveva già scritto Omero nel VI libro dell’Iliade, ma noi non ce ne siamo accorti e di certi poemi epici abbiamo voluto emulare solo le gesta eroiche, perdendoci immagini di rara potenza: Ettore, eroe per eccellenza della Storia, di fronte al pianto spaventato del figlio Astianatte che, vestito da battaglia, non lo riconosce, si toglie l’elmo splendente, simbolo di forza e ferocia, per mostrarsi nelle sue sole vesti di padre.
Forse i tempi potrebbero essere abbastanza maturi per lasciare alla nostra società padri umani. In fin dei conti, di eroi, è già piena la fantasia.